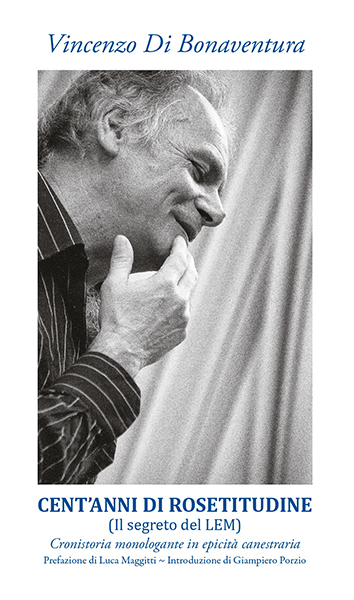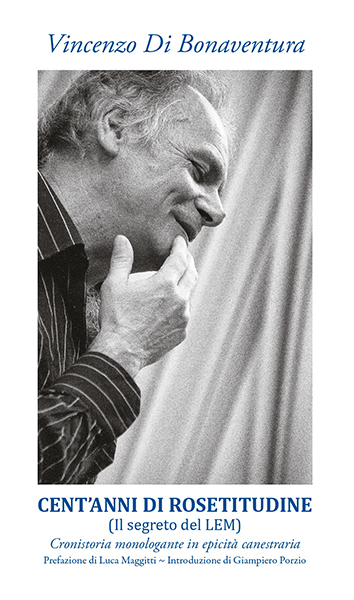Vlade Divac e Drazen Petrovic con la canotta della Jugoslavia. Una foto che riassume il forte legame tra ‘Marlboro Man’ e il ‘Mozart dei canestri’.
Vlade Divac e Drazen Petrovic con la canotta della Jugoslavia. Una foto che riassume il forte legame tra ‘Marlboro Man’ e il ‘Mozart dei canestri’.
 Drazen Petrovic con la canotta del Real Madrid con il quale a fine stagione, prima di conquistare la Medaglia d’Oro agli Europei 1989 di Zagabria, demolisce in finale di Coppa delle Coppe la Snaidero Caserta di Oscar, Gentile ed Esposito segnando 62 punti.
Drazen Petrovic con la canotta del Real Madrid con il quale a fine stagione, prima di conquistare la Medaglia d’Oro agli Europei 1989 di Zagabria, demolisce in finale di Coppa delle Coppe la Snaidero Caserta di Oscar, Gentile ed Esposito segnando 62 punti.
 Frammento della bandiera jugoslava.
Frammento della bandiera jugoslava.
|
La tesi di laurea, a puntate, del giovane teatino appassionato di basket. Puntata 10.
Roseto degli Abruzzi (TE)
Giovedì, 23 Gennaio 2020 - Ore 10:00
III.5: Vlade Divac e Dražen Petrović
L’XI Campionato Mondiale Maschile di Pallacanestro si disputò, come detto, in Argentina, dall’8 al 19 agosto 1990. Fu l’occasione per vedere all’opera la generazione più forte di cestisti jugoslavi che, di fatto, non avrebbero tradito le attese issandosi sul gradino più alto del podio. Ma il Mondiale argentino fu all’insegna di due atleti che vissero l’atrocità della guerra sulla propria pelle passando da colleghi inseparabili a “nemici”: Vlade Divac e Dražen Petrović.
L’unico modo per comprendere il reale peso del gesto di cui si sarebbe reso protagonista Divac al termine della finale con la bandiera croata, è analizzare il rapporto che intercorreva tra i due ed il legame fraterno tra un serbo ed un croato, ancora jugoslavi. Un legame irrimediabilmente spezzato e, per la prematura scomparsa di Petrović nel 1993, mai ricucito.
Nel 2010 l’ESPN produsse un film documentario (Once Brothers) per ripercorrere le carriere dei due grandi cestisti e per mettere in luce il rapporto interetnico tra i vari membri della nazionale vincitrice in Argentina ’90, attraverso le parole dei protagonisti dell’epoca. Divac e Petrović: un binomio che, nello sport ad alti livelli, non conobbe eguali. Due compagni di stanza e di squadra accomunati dalla passione per la pallacanestro e uniti sotto la stessa bandiera, quella della Jugoslavia titina.
Petrović nacque a Sebenico nel 1964. Divac a Prijepolje, quasi al confine tra la Serbia ed il Montenegro, nel 1968. Contrariamente a quanto si pensasse, i due non fecero tutta la trafila giovanile insieme perché il primo, un vero e proprio talento del basket, venne promosso, al compimento del suo quindicesimo compleanno, tra i professionisti mentre Divac, a causa anche di una maturazione più lenta, approdò nella nazionale maggiore più tardi. La prima occasione per vederli insieme, nonostante le voci sul loro conto fossero sempre più positive e gli aneddoti sulle prodezze del croato si allargassero a macchia d’olio, fu all’Olimpiade di Seoul del 1988.
In preparazione della competizione, scattarono i meccanismi da paese comunista, pur essendo ormai la fine degli anni Ottanta. La nazionale venne portata in ritiro a Rogla, in Slovenia, dove vi sarebbe rimasta per tre mesi. Il tecnico serbo, Dušan Ivković, si rese conto che certi giocatori avevano una personalità troppo spiccata e compì la scelta più saggia per evitare spaccature: decise d’imperio, senza consultare i diretti interessati, che Drazen sarebbe stato in camera con Vlade. Così l’allenatore mandò un segnale agli altri dieci (atleti, ndr) imponendo la convivenza anche notturna tra il leader dei croati e quello dei serbi (1).
Ma la scelta non fu dettata solo dalla necessità di mantenere un equilibrio politico ma anche dalla capacità di mettere insieme due personalità diametralmente opposte: da una parte Petrović, taciturno, maniaco dell’ordine e concentrato esclusivamente sulla pallacanestro; dall’altra Divac, estroverso, divertente nell’accezione serba del termine (burlone), dal talento cristallino ma per nulla disciplinato come dimostra il suo soprannome, Malboro Man, per la sua smodata passione per il fumo.
Io facevo un po’ da anello di congiunzione tra i vecchi e i nuovi anche se, insieme con Kukoč, ero il più giovane di tutti. Ma io, a differenza dello stesso Toni (Kukoč, ndr) e di Dino Radja che erano appena arrivati, ero già in Nazionale da qualche anno. Sentivo la responsabilità di fare da collante ma non ce ne fu bisogno. Eravamo davvero un gruppo di amici e a nessuno importava da dove venisse l’uno o l’altro. Non ne abbiamo mai parlato una sola volta. Eravamo la Jugoslavia ed eravamo lì per giocare a basket, al meglio delle nostre possibilità. Qualche scricchiolio però si cominciava a sentire. Tito era morto da ormai otto anni e l’economia del Paese era tutt’altro che florida. Partimmo per Seul, con una consapevolezza di squadra sempre maggiore. Ce la saremmo giocata alla pari contro tutti, compresi i due “giganti” di sempre, l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti (2).
Questa era la consapevolezza che, attraverso le parole di Divac, affiorava tra gli atleti jugoslavi: l’idea che davvero la Jugoslavia potesse emulare i fasti del passato, quelli della grande “Jugo” degli anni Sessanta. E la vittoria, all’esordio, sull’Unione Sovietica (92-79) fornì consapevolezza nei propri mezzi e grande autostima. I plavi incontrarono nuovamente i sovietici nel torneo, questa volta in finale, ma il risultato fu diverso. L’URSS, sospinta ancora una volta dagli esperti lituani, colse la rivincita e conquistò la medaglia d’oro.
Ormai la strada verso il successo era spianata per gli slavi del sud che, dopo nemmeno un anno, avrebbero avuto la possibilità di cogliere un’occasione quasi irripetibile ospitando gli Europei del 1989 a Zagabria. In Croazia Petrović giocava in casa, Divac un po’ meno. I venti di secessione cominciarono a spirare ma per il momento fu solo una suggestione. Il Muro di Berlino sarebbe caduto di lì a qualche mese ma nessuno poteva saperlo. Dunque l’attenzione generale era rivolta a un grande evento sportivo internazionale. Per molti la vittoria nell’Europeo casalingo sembrava una semplice formalità. La squadra era fortissima e la maturazione dei “nuovi” ormai completata. Petrović viveva con estrema fiducia quel momento sportivo:
Il nostro Europeo. Così chiamavamo tra di noi la competizione continentale che stava per iniziare nel giugno del 1989 a Zagabria. E non ci riferivamo solo al fatto che si sarebbe giocata a casa nostra. Era il “nostro” Europeo perché, semplicemente, nessuno di noi contemplava la possibilità di farsi sfuggire la vittoria. Era passato meno di un anno dall’argento di Seul ma, in realtà, sembrava molto, molto più tempo. In quei nove mesi, molti di noi avevano fatto il salto più importante, difficile e decisivo: quello di passare da grandi promesse a essere atleti “veri”, finiti e completi. E soprattutto il passaggio, ancora più complesso, da ragazzi a uomini. Passaggio che nella vita, come nello sport, arriva solo quando scatta il momento della “assunzione di responsabilità”. Ebbene, quello è stato il momento. Quella è stata la competizione della svolta. Dentro di noi, nelle settimane di ritiro prima dell’inizio degli Europei, ci eravamo assunti, dal primo all’ultimo, la responsabilità di vincere quell’edizione. Io avevo venticinque anni, Dino Radja 22, Vlade Divac e Toni Kukoč 21. Praticamente giovani ma, al tempo stesso, consci che il primo grande momento della verità era arrivato (3).
Mentre Divac seppe riconoscerne un’importanza anche politica:
Quegli Europei erano l’occasione perfetta per arrivare finalmente sul gradino più alto del podio in una manifestazione di vertice. Ed era un momento doppiamente importante perché proprio in quell’anno iniziarono quei gravi problemi che di lì a poco avrebbero scatenato una guerra che ci avrebbe diviso per sempre. Una crisi economica devastante, la produzione industriale che iniziava a segnare un crollo vertiginoso. L’inflazione a livelli spaventosi e quasi un milione e mezzo di disoccupati, oltre un quarto della popolazione attiva. Noi però eravamo lontani, fisicamente e mentalmente, da quel processo. Noi stavamo pensando alla Grecia, campione d’Europa in carica, che ci aveva battuto in finale due anni prima e che era ancora una grande squadra, non solo per la presenza di quel fenomeno di Nikos Galis. C’erano ovviamente i sovietici di Sabonis, Volkov e Sokk, smaniosi di vendicarsi dallo smacco subito proprio dai greci due anni prima. C’erano gli spagnoli e gli italiani pronti a stupire, anche se obiettivamente un gradino sotto. Passeggiamo sul velluto nel girone di qualificazione, sconfiggendo nettamente anche i Greci, per affrontare poi l’Italia nei quarti di finale. Sandro Gamba, l’esperto coach italiano, mise in campo una formazione ricca di talento e di esperienza. D’Antoni, Magnifico, Riva, tutti giocatori di altissimo livello. Ma il lavoro svolto nelle lunghe settimane di preparazione stava pagando come non mai. Non solo i nostri meccanismi di gioco erano ormai oliati alla perfezione, ma era diventato tutto perfetto, le condizioni psicofisiche, eccellenti. In più c’era finalmente quella consapevolezza che tutti quanti, giocando al massimo delle nostre possibilità, fossimo diventati praticamente imbattibili. I diciassette punti di margine alla fine del match la dicono lunga sulla nostra prestazione. E pensare che i diciassette punti sono stati il margine più striminzito con cui abbiamo battuto le nostre avversarie in questo Europeo. Si, perché nella finale non c’è stata storia. Vincere con ventuno punti di vantaggio sui greci significava solo una cosa: grande risultato ma l’Europa non ci bastava più (4).
Alla Dom sportova (impianto sportivo polivalente di Zagabria), per la finale contro la Grecia del 25 giugno, c’era un clima strano, in palese contrasto con quanto stava accadendo nel resto del Paese: raramente si era visto un tifo così per la Jugoslavia, come se gli sportivi volessero rimarcare una propria diversità. Non a caso tutti i giocatori in campo avrebbero ricordato l’Europeo di Zagabria con la pelle d’oca. Per Drazen fu l’ultima apparizione vera davanti alla sua gente (5).
Ma la finale mise allo scoperto anche un’altra verità. Durante la cerimonia di premiazione, tutti gli atleti jugoslavi cantarono a squarciagola l’inno nazionale, tutti salvo lo sloveno Juze Zdovc che seguì compunto ma in assoluto silenzio. Questo episodio sollevò un grande polverone, soprattutto da parte dei giornali serbi che videro in ciò la conferma lampante delle velleità secessionistiche della Slovenia (6). Lo stesso Zdovc che si sarebbe reso protagonista (questa volta tristemente) di un dramma sportivo ben più grave, negli Europei del 1991 a Roma.
NOTE
(1) S. Tavčar, La Jugoslavia, il basket e un telecronista, cit, pag. 102-103.
(2) Remo Gandolfi, Dražen Petrović e Vlade Divac: una volta eravamo fratelli, articolo del 7 giugno 2018 pubblicato sul sito “Storie Maledette”.
(3) Ivi
(4) Ivi.
(5) S. Olivari, Gli anni di Dražen Petrović, cit, pag. 120.
(6) S. Tavčar, La Jugoslavia, il basket e un telecronista, cit, pag. 157.
ROSETO.com
Emanuele Di Nardo
TUTTI GLI ARTICOLI
https://www.roseto.com/news.php?id_categoria=116&tipo=basket
Emanuele Di Nardo
|